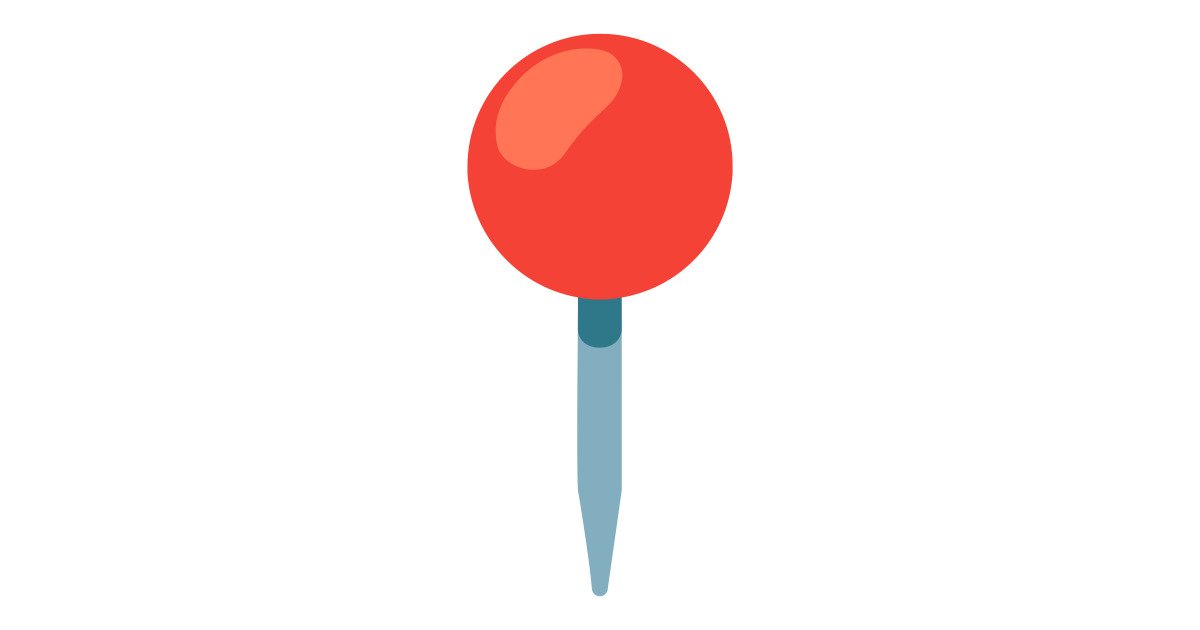Gli spilli possono servire a molte cose.
A fissare una foto o un foglietto di appunti su di una bacheca.
A tenere provvisoriamente insieme due lembi di stoffa in attesa di un più duraturo rammendo.
A infliggere una piccola puntura, solo leggermente dolorosa, a qualcuno che forse l’ha meritata.
Lo spillo di oggi è dedicato ad una singolare escogitazione:
Linee guida del CSM per “disciplinare” libertà e diritti dei magistrati?
Un’iniziativa inammissibile
Sul quotidiano Il Domani del 9 aprile si dà notizia di un’iniziativa assunta dal Consigliere laico del CSM Felice Giuffrè: l’apertura di una pratica «per la definizione delle linee guida in ordine alla partecipazione dei magistrati ad eventi pubblici e per l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, di riunione e di associazione nel rispetto dell’interesse costituzionale alla garanzia del prestigio, della credibilità, dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura».
Vasto programma ed obiettivo ambizioso. Se non fosse che i diritti fondamentali dei magistrati - di parola, di riunione, di associazione – e l’equilibrio tra tali diritti e i valori di indipendenza, imparzialità e credibilità della magistratura sono già scritti in testi più solenni ed impegnativi di una circolare del CSM.
La Costituzione innanzitutto. E poi le norme del codice disciplinare e del codice etico dei magistrati e le sentenze della Corte costituzionale, della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che su questi temi hanno detto parole chiare ed esaustive.
E’ singolare che mentre si contesta l’esercizio di poteri espressamente attribuiti al Consiglio Superiore dalla legge o direttamente “strumentali” rispetto alle sue competenze normative, si pretenda di ampliare a dismisura il suo raggio di azione, letteralmente “inventando” una sua funzione di orientamento ideale e di precettore dei magistrati.
Negli atti di amministrazione e nelle sentenze del giudice disciplinare il Consiglio ha certamente modo di pronunciarsi più volte su questioni attinenti alla presenza ed alla parola pubblica dei magistrati.
Ma ciò avviene in attività di “puntuale” applicazione della legge e non nell’esercizio di un autonomo potere di indirizzo e di disciplina che certamente non spetta al Consiglio.
Se mai c’è da lamentare che, di recente, in una pluralità di casi si sia tentato di forzare i limiti naturali dell’istituto del trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, concepito per tutt’altre finalità, per contestare e punire il libero esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.
Tentativi respinti dalla maggioranza dei consiglieri ma espressivi di una tendenza illiberale che mira ad ammonire i magistrati dall’esprimere opinioni sgradite al potere, agitando la prospettiva di un trasferimento forzato.
Nel “rumore” e nella “furia” che ormai connotano sistematicamente le discussioni sulle questioni di giustizia, sarebbe bene che l’intero Consiglio restasse un luogo di razionalità giuridica ed istituzionale, senza prestarsi a fare da sponda a spericolate operazioni di irreggimentazione e compressione dei diritti dei magistrati.
Il Consiglio Superiore è organo di “amministrazione della giurisdizione”, non la guida paternalistica né l’occhiuto guardiano dei magistrati sul terreno dei loro diritti e delle loro libertà.
Se ne prenda atto e ci si concentri, più utilmente, sui molti, importanti e gravosi compiti di istituto.
QG