Sommario: 1. Una norma convenzionale di difficile lettura: la possibilità di una “revisione contra reum” - 2. Quasi tutta la dottrina penalistica italiana sceglie di non occuparsi della norma convenzionale sulla revisione contra reum - 3. I pochi interventi italiani di dottrina sul tema della revisione contra reum - 4. I Paesi membri del Consiglio d’Europa che hanno inserito la revisione contra reum nei loro sistemi processuali - 5. I modelli di revisione contra reum nel Regno Unito, in Irlanda e nei Paesi Bassi - 6. La sentenza del 2005 della Corte di cassazione sulla strage di Piazza Fontana riconosce che l’assoluzione di Freda e Ventura è contraddetta da nuove prove di colpevolezza - 7. Gli aspetti paradossali della sentenza di legittimità del 2005 e delle due sentenze di merito che l’hanno preceduta - 8. Da Piazza Fontana a Piazza della Loggia: la sentenza del 2015 sulla strage di Brescia, la centralità del dichiarante Digilio e le nuove evidenze sulla posizione di Delfo Zorzi - 9. Come le due recenti sentenze sulla strage di Bologna aprano nuove prospettive per la revisione contra reum in Italia, e come sia prematuro valutare tali prospettive in questo saggio.
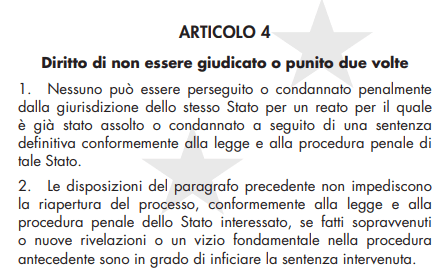
1. Una norma convenzionale di difficile lettura: la possibilità di una “revisione contra reum”
Una prima lettura congiunta dei commi primo e secondo dell’art. 4, Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), ci porta necessariamente a concludere che tale norma convenzionale – regolarmente ratificata dall’Italia – stabilisce che non solo l’imputato «condannato», ma anche l’imputato «assolto» con sentenza definitiva, può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo reato, «se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta». Il Rapporto esplicativo della Corte europea, inoltre, conferma espressamente che «il processo penale può essere riaperto non solo in favore, ma anche in danno della persona o delle persone interessate».[1]
Per evitare eccessive ripetizioni, d’ora in poi chiameremo “revisione contra reum” la riapertura del processo per il medesimo fatto-reato dal quale l’imputato è stato in precedenza assolto con sentenza definitivamente confermata dalla Corte di cassazione.
Siamo quindi di fronte a una norma convenzionale che, almeno apparentemente, sembrerebbe rinnegare il principio del ne bis in idem: vale a dire quel principio che – di regola – impedisce la revisione contra reum. A ben vedere, tuttavia, la norma convenzionale lascia intendere, ancorché per via indiretta e in termini sibillini, che la revisione contra reum può sì verificarsi, ma solo in circostanze del tutto eccezionali.
Infatti, nel secondo comma dell’art. 4 del Protocollo CEDU n. 7 (d’ora in avanti, “Protocollo 7” o “prot. 7”), il legislatore convenzionale ha tenuto a precisare che il principio del ne bis in idem, previsto dal comma 1, non impedisce totalmente la revisione contra reum, ma l’ammette solo a condizione che tale riapertura avvenga «conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato». Ebbene, se il legislatore convenzionale ha voluto inserire in quella norma queste ultime parole (apparentemente superflue, essendo ovvio che l’apertura di un processo deve essere conforme alle leggi dello Stato interessato), ciò vuol dire che tali parole devono e possono assumere, in realtà, un significato più specifico e preciso di quanto appare a prima vista, vale a dire un significato plausibile, che però sia comunque desumibile dal sistema penale dello Stato interessato.
In altri termini, quelle dieci parole («conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato») vanno «interpretate». E vanno interpretate secondo i canoni classici di interpretazione delle norme giuridiche, che obbligano l’interprete – appunto – ad attribuire sempre un significato plausibile a ogni parte della norma giuridica che viene in considerazione. Ciò perché una norma giuridica può sì contenere parole, a volte, di difficile interpretazione (come nel nostro caso), ma mai parole “inutili” che possano essere semplicemente ignorate. Nel caso del secondo comma dell’art. 4 prot.7, si tratta di interpretare una norma convenzionale ratificata dall’Italia, il che comporta il rispetto dei vincoli di cui all’art. 117 comma 1 della nostra Costituzione, vale a dire il rispetto dei vincoli «derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ebbene, tra questi “vincoli” c’è anche quello di rispettare l’esigenza che l’eccezionale ammissibilità della “revisione contra reum” possa verificarsi – appunto – solo se «conforme alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato», come espressamente previsto dalla norma convenzionale.
Il senso di questa “conformità” va ricercato attentamente dall’interprete, perché esso non è immediatamente riconoscibile. Esso, inoltre, va ricercato anzitutto nella legge penale sostanziale (vale a dire nel Codice penale) del Paese che ha sottoscritto la Convenzione, perché è nel Codice penale che si possono individuare crimini talmente gravi e organizzazioni criminali talmente pericolose per il Paese, da giustificare un rimedio processuale estremo come la revisione contra reum.
Ed ecco allora che la «conformità» della revisione contra reum alla legge penale italiana è ravvisabile nell’ultimo comma dell’art. 157 del Codice penale, che dichiara imprescrittibili i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo. A ben vedere, infatti, lo “spirito” della norma interna italiana sull’imprescrittibilità dei reati da ergastolo (come le stragi e gli omicidi volontari aggravati) sembra corrispondere allo "spirito" della norma CEDU, la quale considera processabile una seconda volta una persona già processata e assolta per lo stesso reato, anche dopo decenni (dovrà quindi trattarsi di un reato di gravità eccezionale), e solo «se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza» già intervenuta in passato. In altri termini, l'idea è che, nei casi gravissimi attinenti ai crimini imprescrittibili (e tanto più ai «crimini contro l’umanità», quali definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale), la possibilità di una revisione contra reum – ammessa dal Protocollo 7 – troverebbe sponda nel diritto interno italiano proprio grazie all’art. 157 del Codice penale. Come dire che la «conformità» della revisione contra reum alla legge penale sostanziale italiana è ravvisabile proprio grazie alla presenza nel suo Codice penale dell’art. 157.
Sappiamo però che la norma italiana dell’art. 649 del Codice di procedura penale («Divieto di un secondo giudizio») è sempre rimasta invariata nella sua formulazione originaria, che ha escluso in modo assoluto qualsiasi revisione contra reum. Quindi non sono mai intervenute iniziative del legislatore italiano che potessero realizzare una «conformità», tra la nostra legge penale processuale e la revisione contra reum, e che rendessero così possibile tale tipo di revisione, sia pure entro limiti ben precisi: vale a dire nei casi di eccezionale gravità che si sono già indicati, ma anche eventualmente con modalità eccezionali – sul piano processuale – destinate a salvaguardare i diritti di tutte le parti in causa. Tali modalità eccezionali di tipo processuale ben potrebbero essere inserite in una nuova stesura dell’art. 649 c.p.p., che rendesse possibile, entro quei limiti, la revisione contra reum, ma fino a oggi, in Italia, ciò non è mai avvenuto.
2. Quasi tutta la dottrina penalistica italiana sceglie di non occuparsi della norma convenzionale sulla revisione contra reum
La scelta del legislatore italiano di negare applicabilità, senza eccezione alcuna, alla revisione contra reum si è protratta per ben 33 anni: dal 1992, anno in cui il Protocollo 7 è entrato in vigore nel nostro Paese, sino a tutt’oggi, senza che la Corte europea ravvisasse in ciò una violazione da parte dell’Italia. Ciò ha fatto sì che i pochissimi interventi di dottrina che, nelle nostre facoltà di giurisprudenza, hanno affrontato il tema della revisione contra reum, si siano limitati (quasi tutti) a osservare insistentemente che l’introduzione di una normativa volta a rendere praticabile tale tipo di revisione – nei vari sistemi penali nazionali aderenti alla CEDU – era da considerare meramente facoltativa. Va detto che, in effetti, la stessa Corte europea ha dichiarato la norma convenzionale non già obbligatoria, bensì solo consigliata, in quanto considerata opportuna in situazioni eccezionali. Ma sta di fatto che la dottrina italiana ha preferito non approfondire il tema, scegliendo, in via assolutamente maggioritaria, la soluzione di non ammettere mai la revisione contra reum.
Tutto questo, nonostante fosse apparso chiaramente – almeno a partire dai primi anni Duemila e, come vedremo, da una sentenza del 2005 sulla strage di Piazza Fontana – che depistaggi, frodi processuali e sparizioni di corpi di reato avevano disseminato impunità sulle stragi e sugli omicidi “eccellenti” provocati nel nostro Paese dalla strategia della tensione degli anni Settanta e Ottanta. E nonostante fossero emerse, tra gli ultimi anni Novanta e i primi anni Duemila, prove di gravi responsabilità penali inerenti a tali crimini, che però, trattandosi di prove rivelatesi solo tardivamente rispetto ai relativi processi già celebrati anni prima, avevano lasciato ampiamente impunite quelle responsabilità.
Ebbene, va sottolineato che negli anni più recenti è emersa a poco a poco la consapevolezza dell’esistenza di quelle prove tardive, sfuggite ai processi degli anni più lontani, ed è quindi intervenuta anche la consapevolezza dei dubbi che potevano sorgere su alcune assoluzioni intervenute in quei processi lontani. Questi dubbi emergono anzitutto dalla sentenza antesignana emessa dalla Corte di cassazione nel 2005 sulla strage milanese di Piazza Fontana; poi, dieci anni più tardi, dalla sentenza della Corte d’appello di Milano del 2015 sulla strage bresciana di Piazza della Loggia (ma con riferimenti anche alla precedente strage milanese); infine dalle due sentenze della Corte d’assise di Bologna del 2021 e del 2023 sulla strage bolognese del 2 agosto 1980 e dalle relative conferme in appello e in Corte di cassazione.[2] Su queste sentenze dovremo soffermarci nei capitoli seguenti, anche perché i dubbi che ne emergono, circa la possibilità di errori giudiziari in favore dello stragismo, vengono esplicitati e si sono poi trasmessi agli organi d’informazione e – a partire da lì – alla stessa opinione pubblica.
3. I pochi interventi italiani di dottrina sul tema della revisione contra reum
Il Protocollo CEDU n. 7 è nato oltre quarant’anni fa, precisamente il 22 novembre 1984, ma l’Italia lo ha ratificato solo nel 1990, mentre l’entrata in vigore, per il nostro Paese, è avvenuta, come si è già detto, solo nel 1992.[3] Il primo intervento in dottrina sulle relative norme è stato piuttosto sollecito ed è stato un commento all’art. 4 del Protocollo 7, di Maria Riccarda Marchetti, apparso nel lontano 1991 sulla rivista giuridica Legislazione penale.[4] Marchetti sottolinea che le eccezioni al ne bis in idem sono previste dalla norma convenzionale non solo a favore degli imputati (con l’istituto della revisione previsto dall’art. 630 c.p.p.), ma anche in loro danno: Il "Rapporto esplicativo" della Corte europea dei diritti dell'uomo, un documento che accompagna il testo della Convenzione, afferma del resto in modo esplicito che il processo può essere riaperto “sia in favore, sia in danno” della persona interessata, «quando emergano fatti nuovi o nuove rivelazioni, o se risulti aver avuto luogo un vizio fondamentale nella procedura».[5] Dopo di che l’autrice non affronta il tema di un possibile intervento legislativo che, in via eccezionale, renda praticabile in Italia la revisione contra reum. Ciò perché, avendo preso atto che la stessa Corte europea considera tale intervento non già come un obbligo, ma solo come una libera scelta, opta liberamente, almeno per il momento, per la soluzione negativa. Del resto, nel 1991 la norma convenzionale non era ancora vigente, essendo destinata a entrare in vigore solo l’anno successivo.
Dopo il saggio di Marchetti, pare proprio che, per molti anni, nessun intervento di dottrina si sia mai occupato davvero seriamente e a fondo della revisione contra reum, così come prevista dal secondo comma dell’art. 4 prot.7. Ci sono stati diversi accenni all’argomento molto fugaci, ma mai nessun reale approfondimento.[6]
Nel 2020 comparirà il volume di Roberta Casiraghi dal titolo La Revisione. In questo testo, l’autrice tratta anche il tema della revisione contra reum, ma di sfuggita e in termini decisamente negativi. Casiraghi sottolinea «come dagli atti e dalla giurisprudenza europea emerga una mera tolleranza verso una modifica peggiorativa del giudicato, senza che in alcun modo possa trarsi la convinzione dell’esistenza di un obbligo a carico dei singoli Stati di introdurre nel loro ordinamento una forma di revisione in pejus». Dopo di che, l’autrice conclude che «nemmeno il rilievo che sempre più sta assumendo la vittima del reato in ambito sovranazionale sembra imporre un obbligo di riaprire il procedimento nei confronti del definitivamente prosciolto».[7]
Nel 2016 compare invece un saggio di dottrina piuttosto completo, di autori vari, dedicato alle impugnazioni straordinarie, a cura di Paola Corvi. La stessa curatrice del volume è anche l’autrice del capitolo intitolato «La revisione in pejus», che è anche l’unico contributo che, in tutta la produzione italiana di dottrina, si esprima nettamente in favore della possibilità di inserire una forma di revisione contra reum nel sistema giudiziario italiano, con modalità tali da salvaguardare i diritti di tutte le parti in causa:
«La scelta di introdurre la revisione delle sentenze di proscioglimento potrebbe rispondere alla crescente attenzione per la persona offesa dal reato, i cui rilevanti interessi richiedono una più intensa tutela, riconosciuta anche a livello internazionale, come testimonia la direttiva 2012/29/UE,[8] ma negata, di fatto, dal diritto positivo che, escludendo la revisione del proscioglimento, trascura gli effetti pregiudizievoli derivanti da tale preclusione sul piano degli interessi, patrimoniali e morali, della parte civile»[9].
In effetti, la direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, offre un decisivo supporto nella direzione di favorire l’introduzione di una forma di revisione contra reum nei sistemi giuridici europei. La direttiva segna chiaramente una svolta, laddove riconosce che il reato non rappresenta soltanto un’offesa all’ordine giuridico statale, ma costituisce soprattutto una «violazione dei diritti individuali della vittima». La direttiva, inoltre, attribuisce alla vittima il diritto a chiedere la revisione delle decisioni di non esercitare l’azione penale, introducendo così un principio generale: la vittima non può essere privata di giustizia a causa di decisioni che impediscono l’accertamento del reato, il che rafforza la prospettiva di una revisione contra reum, regolata da tutte le garanzie necessarie.[10]
4. I Paesi membri del Consiglio d’Europa che hanno inserito la revisione contra reum nei loro sistemi processuali
Al fine di approfondire il tema della revisione contra reum, e data la scarsa attenzione dedicata all’argomento dalla dottrina italiana, sembra opportuno rivolgere lo sguardo verso sistemi giuridici diversi da quello italiano, dal momento che il Protocollo 7 è stato ratificato non solo dall’Italia, bensì anche da tutti gli altri 45 Paesi del Consiglio d’Europa, l’organizzazione internazionale fondata nel 1949 che ha elaborato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, alla quale appartiene il Protocollo 7.
Lo scopo è quello di verificare quali sono, tra i Paesi europei con cui l’Italia ha maggiori legami politici e culturali, quelli che hanno non solo ratificato il Protocollo CEDU, ma hanno anche scelto di adeguare il loro sistema processuale alla norma che prevede quel tipo di revisione. Si è potuto così accertare che molti tra i Paesi più culturalmente affini all’Italia hanno optato per l’introduzione della revisione contra reum nei loro sistemi giudiziari, con modalità e misure particolarmente attente onde salvaguardare i diritti di tutte le parti in causa: così Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Norvegia, Svezia e Svizzera. Altri Paesi hanno invece mantenuto una posizione di chiusura: così – oltre all’Italia – Albania, Belgio, Francia, Grecia, Lussemburgo, Spagna e Slovenia. Una posizione a sé stante occupa, in questi ultimi anni, la Germania, che sulle prime ha introdotto nella sua legislazione la revisione contra reum, poi dichiarata incostituzionale dalla Bundesverfassungsgericht, con la conseguenza che la dottrina penalistica tedesca è attualmente impegnata in un interessantissimo dibattito sul tema[11].
Tra le varie soluzioni scelte da Paesi che hanno inserito l’istituto della revisione contra reum nei loro sistemi giudiziari, particolarmente interessanti, razionali ed efficienti sono quelle adottate dal Regno Unito, dall’Irlanda e dai Paesi Bassi, che possono essere utilmente prese in considerazione ed eventualmente adottate anche nel nostro Paese. Ad esse è dedicato il prossimo capitolo.
5. I modelli di revisione contra reum nel Regno Unito, in Irlanda e nei Paesi Bassi
A) Regno Unito
In Inghilterra e nel Galles, la revisione contra reum nasce nel 2003. È da allora che la legge britannica consente, in casi eccezionali, di togliere efficacia a un’assoluzione definitiva e di rifare il processo, ma solo per un elenco chiuso di reati gravissimi (omicidio, strage, gravi reati sessuali, terrorismo e altri reati espressamente indicati dalla legge). La base normativa del nuovo istituto è il Criminal Justice Act 2003, e precisamente la Parte 10, Retrial for Serious Offences.
Due sono le condizioni centrali: anzitutto devono essere intervenute prove nuove molto solide, affidabili e altamente efficaci che siano emerse dopo l’assoluzione; la seconda condizione è che sia intervenuta una decisione da parte della Corte d’appello, secondo cui il nuovo processo corrisponde all’interesse della giustizia e che valuti l’equità del futuro giudizio, tenuto conto anche del tempo trascorso. Inoltre, è ammessa una sola riapertura possibile per ciascun reato (one-shot).
Il meccanismo è protetto da un doppio filtro. Il primo filtro è l’intervento del Direttore delle Pubbliche Accuse (Director of Public Prosecutions), che deve autorizzare per iscritto sia la riapertura delle indagini sulla persona assolta, sia la domanda indirizzata alla Corte d’appello. Il secondo filtro è appunto il controllo da parte della Corte d’appello, la quale verifica se le prove sono davvero «nuove e decisive» e se rifare il processo è giusto. Solo allora la Corte cancella l’assoluzione e ordina il nuovo dibattimento. La legge disciplina anche gli atti investigativi dopo l’assoluzione (arresto, perquisizioni, prelievi): esse richiedono l’assenso del Director of Public Prosecutions e, di regola, un mandato.
Il modello ha funzionato in alcuni casi simbolo. Nel procedimento per l’omicidio di Stephen Lawrence, la Corte d’appello ha applicato la Parte 10 del CJA e, grazie a nuove prove ritenute molto solide, l’assoluzione è stata cassata e si è celebrato un nuovo processo con condanna.[12]
B) Irlanda
L’Irlanda, sorella gemella di common law del Regno Unito, ha adottato una soluzione molto simile a quella inglese, con il suo Criminal Procedure Act 2010. Anche qui la Corte d’appello può annullare un’assoluzione e disporre un nuovo processo in due situazioni: a) quando emergono prove nuove e convincenti, b) quando la precedente assoluzione risulta “inquinata” da reati contro l’amministrazione della giustizia (corruzione o intimidazione di testimoni, falsa testimonianza, frode processuale, distruzione di prove). Anche qui opera il principio del “tentativo unico” per ciascun reato. Inoltre, la legge disciplina poteri di arresto, ricerca e sequestro post-assoluzione con controllo giudiziario, proprio per massimizzare le garanzie.[13]
C) Paesi Bassi
Il modello di revisione contra reum elaborato dai Paesi Bassi è una variante europea continentale ad alta soglia probatoria. È quindi una costruzione di civil law ed è un modello di revisione che si potrebbe utilmente e facilmente assumere come modello per una futura introduzione della revisione contra reum anche nel sistema giudiziario italiano.
Dal 2013 i Paesi Bassi consentono, in via eccezionale, la revisione a sfavore della persona assolta. La legge ha inserito nel Codice di procedura penale olandese una sezione dedicata, di nove articoli, che permette di riaprire il caso, in particolare per delitti di estrema gravità (con forte attenzione ai casi con esito mortale), quando emerge un «fatto nuovo» davvero decisivo, come possono essere le nuove analisi del DNA o una confessione postuma attendibile. Anche per la legge olandese, è ammessa una sola riapertura per ciascun reato.
La richiesta di revisione viene avanzata dalla Procura generale, mentre la decisione (se sia giusto procedervi) spetta alla Corte suprema olandese, che verifica con rigore l’effettiva novità e forza dimostrativa del materiale probatorio, il che fa sì che la revisione contra reum possa realizzarsi nel rispetto di tutte le garanzie. Tra l’altro, le linee guida fissano cautele anche relativamente agli atti investigativi sulla persona assolta, che vanno regolati e autorizzati.
In conclusione, l’eccezionalità della revisione contra reum, nella legislazione olandese, è davvero autentica: la riapertura del processo è un rimedio raro, garantito e mirato a casi in cui scienza forense o fatti sopravvenuti rendono l’assoluzione non più sostenibile.[14]
6. La sentenza del 2005 della Corte di cassazione sulla strage di Piazza Fontana riconosce che l’assoluzione di Freda e Ventura è contraddetta da nuove prove di colpevolezza
Tornando ora sul versante italiano, è arrivato il momento di prendere in esame le quattro sentenze definitive degli anni Duemila già menzionate nel secondo capitolo di questo saggio: si tratta delle quattro sentenze che, per via del sopravvento di nuove prove, hanno sollevato seri dubbi su alcune assoluzioni intervenute negli anni Ottanta e Novanta per gravi delitti di strage e di omicidio.
La prima di queste sentenze è quella della Corte di cassazione emessa il 3 maggio 2005 e relativa alla strage di Piazza Fontana, la cui motivazione è stata depositata il successivo 10 giugno.[15] La sentenza ha riguardato le accuse elevate tardivamente – negli anni Novanta – nei confronti dei nuovi imputati Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi e Giancarlo Rognoni, incriminati per la strage milanese del 12 dicembre 1969 dal giudice istruttore (poi giudice per le indagini preliminari) Guido Salvini.[16] Senonché, il capo d’imputazione contestato ai tre nuovi imputati era stato formulato precisando che l’accusa era «in concorso con Franco Freda e Giovanni Ventura», i quali però erano stati assolti, da quella stessa accusa, dalla Corte d’assise d’appello di Bari con la sentenza definitiva del 1° agosto 1985, vale a dire di vent’anni prima.
Questa situazione ha generato una sorta di corto circuito che ha costretto la Corte di cassazione – e in particolare il magistrato estensore di questa sentenza del 2005 – ad affrontare finalmente l’anomalia che, sino ad allora, non era stata affrontata: la frequenza, cioè, di nuove e precise evidenze di fatti storici, emerse in anni relativamente recenti, che smentivano seriamente, appunto, la credibilità di talune assoluzioni intervenute in anni precedenti, in processi su gravi fatti di sangue ricollegabili alla strategia della tensione. Come dire che la sentenza del 2005, pur senza fare esplicitamente alcun riferimento alla norma convenzionale del Protocollo 7, si è trovata costretta ad affrontarne comunque taluni aspetti, in un contesto non proprio ideale.
Il punto critico di quel contesto stava proprio nel fatto che la sentenza del 2005 riguardava direttamente i tre nuovi imputati (Maggi, Zorzi e Rognoni), incriminati solo negli anni Novanta (cioè, diversi anni dopo l’assoluzione definitiva di Freda e Ventura), ma paradossalmente incriminati, malgrado ciò, in concorso con i due assolti. Una situazione anomala e davvero inestricabile. Tanto più che i tre nuovi imputati Maggi, Zorzi e Rognoni, che erano stati condannati in primo grado, erano stati poi assolti in appello e l’assoluzione era stata definitivamente confermata dalla sentenza del 2005 della Corte di cassazione.
Come se ciò non bastasse, c’è di più: se Maggi, Zorzi e Rognoni – imputati diretti di questi ultimi processi sulla strage milanese – escono sani e salvi da ogni accusa, non altrettanto si può dire di Freda e Ventura. Infatti, la sentenza della Corte di cassazione del 2005 e le due sentenze di merito che l’hanno preceduta affermano, ancorché solo per inciso, che l’assoluzione di Freda e Ventura del 1985 non è più sostenibile, essendo ormai ampiamente provata la loro responsabilità per la strage di Piazza Fontana, sulla base di nuove prove intervenute dopo quella lontana sentenza. [17]
A questo punto, è il caso di riportare quanto si legge nella sentenza del 10 giugno 2005 a proposito della responsabilità di Freda e Ventura per la strage di Piazza Fontana:
«La sentenza impugnata […] è pervenuta […] ad una conclusione del tutto sovrapponibile a quella già rassegnata al riguardo in prime cure: vale a dire che […] dovesse ritenersi assodato che "a Padova fu costituito, nell’alveo di Ordine Nuovo, un gruppo eversivo capitanato da Freda e Ventura e che ad esso vanno attribuiti una serie di fatti delittuosi consumati nel 1969, tra i quali […] gli attentati ai treni dell’agosto" (pag. 247 della sentenza impugnata). Ma v ’è di più. Anche sul punto specifico delle responsabilità individuali, sia pure in chiave meramente “storica” e di valutazione incidentale, l’approdo dei giudici di secondo grado non si è discostato di molto dai “risultati” dell’indagine condotta in primo grado. Dopo approfondito esame […] delle varie acquisizioni già valorizzate dai primi giudici, anche la Corte dell’appello ha ritenuto di "dover, in definitiva, condividere l’approdo cui la Corte di assise di Milano, peraltro in termini più impliciti che espliciti, è pervenuta in ordine alla responsabilità di Freda Franco e Ventura Giovanni per i fatti del 12.12.1969, pur avvertendo che tale conclusione – cautamente puntualizza la sentenza impugnata – oltre a non poter provocare effetti giuridici di sorta nei confronti di costoro, irrevocabilmente assolti dalla Corte di assise di appello di Bari, è frutto di un giudizio formulato senza poter disporre dell'intero materiale probatorio utilizzato a Catanzaro e Bari". Ebbene, pure con tali limiti e nella […] prospettiva dell’accertamento delle responsabilità di Maggi, Zorzi e Rognoni […] nella forma del “concorso […] con Freda e Ventura”, il giudizio circa la responsabilità di Freda e Ventura nella strage di Piazza Fontana, afferma la sentenza impugnata, "non può che essere uno: il complesso indiziario costituito dalle risultanze esaminate, a cominciare dall’accertamento delle responsabilità irrevocabilmente operate dalle Corti di assise di Catanzaro e Bari per finire con le dichiarazioni di Fabris, Lorenzon […] e Pan, […] fornisce a tale quesito una risposta positiva"»[18].
Questo brano della sentenza di legittimità – estremamente tortuoso e di difficile lettura – non è scevro da contraddizioni, così come non mancano le contraddizioni neppure nei brani che sono lì riportati tra virgolette, come citazioni tratte dalla sentenza d’appello.
Più precisamente, la sentenza d’appello ritiene assodato che al gruppo capitanato da Freda e Ventura «vanno attribuiti una serie di fatti delittuosi consumati nel 1969”, tra cui «gli attentati ai treni», vale a dire gli attentati ‘minori’ del mese di agosto di quell’anno. Subito dopo, però, interviene la sentenza della Corte di cassazione, la quale aggiunge che «v’è di più», dato che la stessa sentenza d’appello perviene anche a riconoscere, proprio come quella di primo grado, «la responsabilità di Freda e Ventura» non solo per i fatti di agosto, ma anche «per i fatti del 12 dicembre 1969». La sentenza della Corte di cassazione prosegue poi definendo logico il tentativo «dei ricorrenti» (cioè dei pubblici ministeri che si oppongono all’assoluzione di Maggi, Zorzi e Rognoni) di valorizzare al massimo il significato delle affermazioni di cui sopra, che sostengono appunto la colpevolezza di Freda e Ventura per la strage. La sentenza, infatti, ammette che l’ormai diffusa certezza circa la responsabilità di Freda e Ventura possa portare anche a «un sensibile rafforzamento del quadro accusatorio riguardante gli imputati Maggi, Zorzi e Rognoni», dato il loro asserito «concorso» con i due imputati «assolti ma colpevoli».
Tuttavia, infine, la sentenza della Corte di cassazione conclude apoditticamente che «l'assunto, certo praticabile in linea astratta e del tutto coerente anche sul piano logico […], non ha trovato positiva conferma sul piano probatorio». Una conclusione contraddittoria, che da un lato ravvisa nell’asserita colpevolezza di Freda e Ventura un rafforzamento del quadro accusatorio riguardante Maggi, Zorzi e Rognoni (ordinovisti concorrenti nella strage); ma che dall’altro lato esclude ogni responsabilità di questi tre imputati, pur ammettendo che il riconoscimento della loro responsabilità penale sarebbe «praticabile in linea astratta e coerente sul piano logico».[19]
7. Gli aspetti paradossali della sentenza di legittimità del 2005 e delle due sentenze di merito che l’hanno preceduta
Tornando ora alla sentenza della Corte d’Assise di Milano del 2001, essa delinea con una certa chiarezza un quadro della strage di Piazza Fontana che poggia su un dato ricostruttivo essenziale: la piena responsabilità storica e operativa di Franco Freda e Giovanni Ventura. Sebbene entrambi siano stati assolti in via definitiva nei procedimenti precedenti, la Corte ne afferma senza esitazioni la colpevolezza “sostanziale”, riconoscendoli come ideatori, organizzatori e principali esecutori dell’attentato.
Ma proprio su questo snodo prende forma il primo – e forse il più clamoroso – dei paradossi argomentativi che attraversano l’intera vicenda giudiziaria. La Corte di primo grado, infatti, pur nella consapevolezza dell’esistenza di un giudicato assolutorio di vent’anni prima in favore di Freda e Ventura, costruisce comunque la colpevolezza degli imputati Maggi, Zorzi e Rognoni come logicamente derivata (o derivata anche) da una “colpevolezza storica” attribuita a Freda e Ventura in quanto gradualmente maturata (appunto “storicamente”) nell’arco di quei vent’anni. In altri termini, un giudicato assolutorio, che dovrebbe avere forza vincolante e preclusiva, viene qui assunto come presupposto fattuale e narrativo per emettere nuove condanne. La contraddizione è evidente: ciò che è stato dichiarato penalmente inesistente per alcuni, diventa vero “oltre ogni ragionevole dubbio” per giudicare altri.
La struttura paradossale non si esaurisce qui. Le sentenze successive – d'appello prima e di Cassazione poi – che pure ribaltano le condanne e assolvono i tre imputati, non recidono il filo logico che lega il fatto storico a Freda e Ventura. Anzi, ne ribadiscono esplicitamente la responsabilità “storica”, anche se si dichiarano giuridicamente impossibilitate a trarne conseguenze processuali. Si determina così una seconda, speculare contraddizione: si afferma che la strage ha autori noti, ma che nessuno può più essere condannato per averla commessa. La verità processuale si chiude su sé stessa, rinunciando a dare forma alla verità sostanziale che essa stessa lascia affiorare.
La dinamica che ne emerge è quella di una giustizia paralizzata dal suo stesso ordinamento, intrappolata tra il rispetto delle garanzie (giustamente inderogabili) e l'esigenza irrisolta di rappresentare compiutamente la realtà del crimine. L’art. 4 prot.7 – che vieta il bis in idem, ma consente, in presenza di «fatti nuovi o errori gravi», la riapertura del processo – resta sullo sfondo, non invocato, quasi rimosso. Eppure, la tensione tra immutabilità del giudicato e incompiutezza del vero permea ogni riga delle motivazioni, fino a raggiungere, nella sentenza della Cassazione del 2005, una forma di tragica sospensione: la strage ha autori, ma non colpevoli.[20]
8. Da Piazza Fontana a Piazza della Loggia: la sentenza del 2015 sulla strage di Brescia, la centralità del dichiarante Digilio e le nuove evidenze sulla posizione di Delfo Zorzi
Il nodo logico evidenziato nel capitolo precedente – una verità storica riconosciuta, ma giudizialmente impotente – trova un naturale proseguimento nella vicenda processuale sviluppatasi alcuni anni dopo, in particolare nei procedimenti per la strage bresciana di Piazza della Loggia, perpetrata il 28 maggio 1974. È in quel contesto che la figura di Carlo Digilio, un collaboratore di giustizia che era stato ritenuto poco credibile dalle sentenze definitive per la strage di Piazza Fontana, ma anche dalle prime sentenze per la successiva strage di Brescia, riemerge nelle sentenze degli anni Duemila con un profilo probatorio ben diverso rispetto a quello che aveva avuto nei processi milanesi e bresciani degli anni precedenti.
Nei giudizi di primo e secondo grado celebrati fino al 2012 a Brescia per la strage compiuta in quella città, le Corti avevano inizialmente valutato Digilio con forte scetticismo, ritenendo inattendibili ampie parti delle sue dichiarazioni accusatorie nei confronti di alcuni imputati. Tuttavia, con la riapertura del processo voluta dalla Corte di cassazione nei confronti di due imputati assolti – Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte – la prospettiva, relativamente alla strage di Brescia, è mutata sensibilmente.
Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte e Delfo Zorzi, membri di Ordine Nuovo incriminati per la strage di Piazza della Loggia, erano stati assolti dalla Corte d’assise d’appello di Brescia nel 2012. La Corte di cassazione, nel 2014, ha annullato con rinvio l’assoluzione di Maggi e Tramonte (confermando invece quella di Zorzi) e ha rinviato, per il nuovo processo a carico dei primi due, non già alla Corte d’assise d’appello di Brescia, che non aveva sezioni diverse disponibili, bensì a quella di Milano. Ebbene, il nuovo processo ha portato alla sentenza di condanna di entrambi gli imputati, emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano il 22 luglio 2015 e nota come sentenza Conforti, dal nome della presidente del collegio giudicante.
La sentenza Conforti compie un’operazione cruciale, innovativa quanto complessa:
a) seleziona e isola le parti del narrato di Digilio coerenti con riscontri esterni e con altre prove testimoniali e documentali;
b) attribuisce credibilità a tali parti, riconoscendo che la collaborazione di Digilio ha fornito – pur con qualche iniziale reticenza – elementi decisamente solidi soprattutto sui fatti del 1969;
c) prende in attenta considerazione le chiare ammissioni di Digilio circa il suo stesso concorso nella strage di Piazza Fontana;
d) collega in modo diretto tali ammissioni autoaccusatorie di Digilio con il ruolo svolto da altri esponenti di Ordine Nuovo;
e) ricostruisce così, infine, un contesto operativo e relazionale che attraversa sia i fatti di Milano che quelli di Brescia.
Più precisamente, la sentenza Conforti si sofferma sui racconti di Digilio corroborati da riscontri esterni e dichiarazioni convergenti (come quelle di Soffiati, Lorenzon, Iuculano, nonché dello stesso Zorzi), soprattutto nelle parti in cui tali racconti descrivono le ormai comprovate e significative dinamiche operative comuni tra le cellule venete e padovane di Ordine Nuovo. Non meno significative sono le dichiarazioni di Digilio sul ruolo degli esplosivi di origine bellica, sui temporizzatori, sulle modalità di innesco e sull’apporto della rete di protezione fornita da ambienti dei servizi.
La sentenza Conforti chiarisce inoltre un punto storico importante: il cosiddetto casolare di Paese, luogo descritto puntualmente da Digilio, situato nei pressi di Treviso e utilizzato per il deposito di armi e di esplosivi e per riunioni operative, era stato nella disponibilità di Giovanni Ventura solo fino all’estate 1969. Questo dato smentisce la tesi, talvolta ripetuta in ricostruzioni meno precise, di riunioni tenutesi in quel casolare nell’autunno del 1969, proprio per preparare la strage di Piazza Fontana. Anche se Digilio non ha mai sostenuto questa tesi, il relativo equivoco di fondo (attribuendo al casolare di Paese utilizzi che esso non poteva avere avuto) ha contribuito a riverberarsi negativamente, ma erroneamente, sulla credibilità delle dichiarazioni del collaboratore. È evidente che gli incontri riguardanti la fase esecutiva della strage milanese si erano svolti in realtà altrove.
Inoltre, ai fini di una rivalutazione delle responsabilità per Piazza Fontana, elemento centrale è la collaborazione di Digilio, il quale non solo ammette di essere coinvolto lui stesso in quella strage, ma dichiara anche che Delfo Zorzi gli ha personalmente confessato di essere stato lui a collocare l’ordigno a Milano il 12 dicembre 1969. Quest’ultima affermazione, considerata attendibile dalla sentenza Conforti, rappresenta un fatto nuovo nella sua valenza processuale, giacché si tratta di un’affermazione che non era stata ritenuta credibile nei precedenti processi su Milano.
Per quanto riguarda la strage di Piazza della Loggia, infine, il passaggio decisivo operato nel processo del 2015 consiste, sul piano probatorio, nell’avere utilizzato le stesse dichiarazioni di Digilio rese a partire dagli anni Novanta non già come prove isolate, ma come nodi di una rete di riscontri incrociati. Da questa rete è derivato un quadro in cui le due stragi, di Milano e di Brescia, non appaiono essere episodi separati, ma tappe di una medesima strategia terroristica che condivide uomini, metodi e finalità, con Freda, Ventura e Zorzi che emergono come punti di contatto. La narrazione di Digilio, pur parziale e a tratti difensiva, fornisce elementi che la Corte del 2015 ha reputato utilizzabili in modo selettivo, ma decisivo, per arrivare alla condanna di Maggi e Tramonte, con la figura di Maggi che emerge come quella di un dirigente pienamente operativo e non già secondario. Condanna – non a caso – poi confermata dalla Cassazione nel 2017.[21]
In conclusione, Freda, Ventura, Maggi, Zorzi e Digilio sembrano essere personaggi chiave sia della strage milanese del 1969 che di quella bresciana del 1974. Attualmente, quelli tra loro tuttora in vita sono Franco Freda (classe 1941) e Delfo Zorzi (classe 1947), entrambi assolti con sentenze definitive rispettivamente del 1985 e del 2012. Le loro rispettive posizioni potrebbero consentire alla Procura o alla Procura generale di Milano (o di Brescia) di assumere l’iniziativa di riaprire le indagini preliminari nei loro confronti, facendo da apripista verso una modifica dell’art. 649 c.p.p., così da renderlo conforme al Protocollo CEDU n. 7. La conseguenza sarebbe, con tutta probabilità, l’intervento della Corte costituzionale, la quale potrebbe ammettere la revisione contra reum nel sistema processuale italiano, dettando tutte le garanzie e tutte le condizioni per renderla conforme ai principi costituzionali; magari prendendo come modello proprio le soluzioni adottate da altri Paesi del Consiglio d’Europa, come i Paesi Bassi, l’Inghilterra, o l’Irlanda.
9. Come le due recenti sentenze sulla strage di Bologna aprano nuove prospettive per la revisione contra reum in Italia, e come sia prematuro valutare tali prospettive in questo saggio
Arriviamo così alle due sentenze della Corte d’assise di Bologna del 2021 e del 2023 sulla strage del 2 agosto 1980, che ha semidistrutto la stazione ferroviaria del capoluogo emiliano facendo 85 morti e oltre 200 feriti. Le due sentenze, con le relative conferme in appello e in Corte di cassazione, hanno condannato alla pena dell’ergastolo rispettivamente Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, come autori della strage bolognese in concorso con Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, già condannati in precedenza con sentenze definitive.
Sia la sentenza Cavallini (oltre 2.000 pagine) che la sentenza Bellini (oltre 1.700 pagine) sono nate grazie alle iniziative e alle ricerche promosse dall’Associazione delle vittime della strage bolognese. Esse hanno permesso di raccogliere nuove prove di notevole rilievo non solo su quella strage, ma anche su altri crimini, sia degli anni Ottanta che degli anni Novanta: dai cosiddetti omicidi di “politica mafiosa” (come quelli di Michele Reina e Piersanti Mattarella) fino alle stragi del 1992 e 1993, ancora ricche di problemi irrisolti, spesso dovuti a depistaggi estremamente insidiosi. Anche alcune delle nuove prove emerse da queste due maxi-sentenze possono riguardare posizioni di imputati assolti in anni lontani.
Tuttavia, mentre le attuali situazioni probatorie relative alle stragi di Piazza Fontana e di Piazza della Loggia si prestano ad essere gestite (per motivi riconducibili al Protocollo CEDU n. 7) anche nell’immediato, dagli uffici giudiziari competenti di Milano e Brescia, ben diverse appaiono le situazioni probatorie relative ai gravi crimini commessi dagli anni Ottanta in poi, di competenza di altri distretti giudiziari. In altri termini, i tempi potrebbero non essere maturi per riaperture di processi (per motivi riconducibili al Protocollo CEDU n. 7) vuoi da parte della Procura di Palermo (per qualche omicidio di “politica mafiosa”), vuoi da parte della Procura di Firenze (per una delle stragi del 1993). Ragion per cui, questo saggio sulla possibilità di introdurre una revisione contra reum nella legge penale italiana, almeno per il momento, non va oltre questo punto.
Postilla
La materia di questo saggio è delicata e l’argomento può rivelarsi "divisivo". Tuttavia, la strage – ormai remota – di Piazza Fontana, nonché le posizioni personali di Franco Freda e Delfo Zorzi (il primo ormai ottantaquattrenne, il secondo quasi ottantenne e da decenni cittadino giapponese non estradabile) consentono da un lato di evitare misure cautelari afflittive, dall’altro di far sì che venga adita la Corte costituzionale, perché essa valuti se sia o non sia opportuno introdurre nel sistema giudiziario italiano (e a quali condizioni) una forma, il più possibile garantita, di revisione contra reum.
[2] Tutte queste sentenze sono accessibili in rete tramite https://memoria.cultura.gov.it/documenti-online.
[3] L’Italia ha ratificato il Protocollo in questione il 9 aprile 1990, attraverso la legge 9 aprile 1990, n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1990. L’entrata in vigore del Protocollo per l’Italia è intervenuta il 1° febbraio 1992 (oltre due anni dopo l’entrata in vigore dell’attuale codice di procedura penale), come da art. 6 del Protocollo 7, che ne condizionava l’entrata in vigore alla ratifica da parte di almeno sette Stati membri.
[4] Maria Riccarda Marchetti, Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: commento all’art. 4, in Legislazione penale, 1991. In particolare, le eccezioni al principio del ne bis in idem di cui al comma 2 dell’art. 4 vengono trattate dall’autrice alle pp. 248-253.
[5] Si riporta il testo originale del Rapport explicatif, nelle parti relative all’art. 4 del Protocollo 7 che sono richiamate espressamente da Marchetti (p. 252, nota 18): «Cet article établit le principe selon lequel une personne ne peut être poursuivie ou punie pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif (non bis in idem) […]. Le principe établi dans cette disposition s'applique uniquement après l'acquittement ou la condamnation de l'intéressé par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénales de l'Etat concerné […]. Le procès peut toutefois être réouvert, conformément à la loi de l'Etat concerné, à la suite de l'apparition de faits nouveaux ou nouvellement révélés, ou s'il apparaît qu'il y a eu un vice fondamental dans la procédure, susceptibles d'affecter l'issue du procès soit en faveur, soit au détriment de la personne concernée […]» (Conseil de l’Europe, Rapport explicatif relatif au Protocole n. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Strasbourg, 1985, punti 26, 29 e 30, accessibile in rete tramite https://rm.coe.int/16800c972b).
[6] Il saggio di Maria Riccarda Marchetti, tuttavia, ha fatto scuola ed è citato più volte, con riferimento alla revisione contra reum, tra l’altro anche in una tesi di laurea dell’Università statale di Milano, anno accademico 2016-2017 (Daiana Giraldin, Ne bis in idem tra Carta dei diritti fondamentali e Convenzione applicativa dell’Accordo di Schengen).
[7] Roberta Casiraghi, La revisione, Milano 2020, p. 40. Altri saggi di dottrina comparsi in Italia e attinenti al Protocollo CEDU n. 7, ma che non affrontano a fondo il tema di un’ipotetica introduzione della revisione contra reum nella legge del nostro Paese, sono Lorenzo Bernardini, Reopening Criminal Proceedings and Ne Bis in Idem: Towards a Weaker Res Iudicata in Europe?, in European Papers – A Journal on Law and Integration, Vol. 9 (2024), n.1, pp. 311 sgg.; Francesco Callari, La rivisitazione in malam partem del giudicato penale: dal contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata ad orizzonti futuribili, in disCrimen, Criminalia, 2018, (che ipotizza una revisione contra reum in Italia, ma soltanto se l’imputato – collaboratore di giustizia – ha ottenuto benefici premiali grazie a una collaborazione rivelatasi falsa: la revisione, secondo questo autore, può intervenire solo relativamente ai benefici concessi); Rosa Anna Ruggiero, Proscioglimento e ne bis in idem nel doppio binario sanzionatorio, Torino, 2022 (l’autrice tratta l’estensione del ne bis in idem agli illeciti amministrativi punitivi, nell’ambito dei sistemi caratterizzati dal doppio binario sanzionatorio).
[8] Si tratta della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, accessibile in rete tramite https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32012L0029.
[9] Paola Corvi, La revisione in pejus, in Le impugnazioni straordinarie nel processo penale, a cura di P. Corvi, Torino 2016, p. 114 sgg. Paola Corvi è docente di Diritto processuale penale presso l’Università Cattolica di Milano.
[10] Direttiva 2012/29/UE, cit., considerando n. 9 e art. 11.
[11] In Germania, nel dicembre 2021, il legislatore federale aveva introdotto nel codice di procedura penale (StPO) l’art. 362 n. 5, denominato Wiederaufnahme zuungunsten des Freigesprochenen (Nuovo processo a scapito della persona assolta), fondato su nuovi fatti o prove relativi ad alcuni delitti gravissimi, tra cui l’omicidio. Tuttavia, con sentenza 31 ottobre 2023, la Corte costituzionale federale ha dichiarato incostituzionale tale norma, tornando al divieto assoluto del bis in idem. La Corte federale, tuttavia, non ha chiuso completamente la porta a una forma di revisione contra reum che sia maggiormente garantita di quella introdotta nel 2021. Tra i contributi di dottrina intervenuti di recente, particolarmente interessanti sono i seguenti: Stefanie-Christine von Bierbrauer zu Brennstein, Der neue § 362 Nr. 5 StPO im System der Wiederaufnahmegründe, in HRRS – Höchstrichterliche Rechtsprechung im Strafrecht, 3/2022, pp. 118 ss.; Ulrich Magnus, Verfassungswidrigkeit der Neuregelung zur Wiederaufnahme des Strafverfahrens – Folgen für die Praxis der Strafverfolgung, in KriPoZ – Kriminalpolitische Zeitschrift, 1/2024, pp. 54 ss.; Verena Berger, Die Neuregelung der Wiederaufnahme des Verfahrens zu Ungunsten des rechtskräftig Freigesprochenen gem. § 362, Nr. 5 StPO, in Aktuelle Entwicklungen im Straf- und Strafprozessrecht, a cura di Anja Schiemann, 2024, vol. 1, pp. 69–90. Questi autori ritengono giustificata – se adeguatamente limitata e strutturata come eccezione assoluta – l’apertura alla revisione contra reum per i delitti più gravi, con una soglia probatoria decisamente elevata, con una formulazione più garantita e con garanzie procedurali rafforzate.
[12] Sull’omicidio – per ragioni razziali – di Stephen Lawrence, avvenuto a Londra nel 1993, si veda Wikipedia, Murder of Stephen Lawrence: «On 18 May 2011, after a further review, it was announced that two of the original suspects, Gary Dobson and David Norris, were to stand trial for the murder in the light of new evidence. At the same time, it was disclosed that Dobson's original acquittal had been quashed by the Court of Appeal, allowing a retrial to take place».
[13] Criminal Procedure Act 2010, Part 3 (retrial following acquittal): section 8 (tainted acquittal), section 9 (new and compelling evidence), section 10 (retrial order).
[14] Nel Codice di procedura penale olandese (Wetboek van Strafvordering) oggi in vigore, la revisione contra reum è disciplinata agli artt. 482.a – 482.i. L’attuale Codice di procedura penale olandese risale al 1926 e sarà sostituito tra qualche anno da quello nuovo, che entrerà in vigore nel 2029. La disciplina della revisione contra reum rimarrà immutata e comparirà, nel nuovo codice, nel Libro 5°, Titolo 8.2, Herziening ten nadele (Revisione a scapito), articoli 5.8.27 – 5.8.35.
[15] Si tratta della sentenza della Corte di cassazione, Sezione 2^, n. 21998/2005 (Maggi + 3), emessa il 3 maggio 2005 e di cui è stata pubblicata la motivazione il 10 giugno 2005.
[16] Maggi, Zorzi e Rognoni erano stati incriminati dal giudice istruttore di Milano, Guido Salvini, con sentenze-ordinanze del 18 marzo 1995 e del 3 febbraio 1998.
[17] Più precisamente, la sentenza del 2005 ha confermato l’assoluzione di Maggi, Zorzi e Rognoni, decisa dalla Corte d’assise d’appello di Milano con la sentenza del 12 marzo 2004. I tre imputati erano stati invece condannati alla pena dell’ergastolo dalla sentenza di primo grado emessa dalla Corte d’assise di Milano del 30 giugno 2001. Quanto al giudizio di colpevolezza – puramente accademico – di Freda e Ventura per la strage di Piazza Fontana, è il caso di sottolineare ulteriormente che esso è condiviso dalla sentenza di legittimità, nonché da entrambe le sentenze di merito, pur opposte tra loro circa la responsabilità di Maggi, Zorzi e Rognoni.
[18] Cass., sentenza 10 giugno 2005, cit., pp. 33-34. Il brano qui riportato presenta diversi omissis, perché il testo completo, accessibile in Archivi per non dimenticare (https://memoria.cultura.gov.it/documenti-online), contiene un eccesso di proposizioni subordinate e altri incisi che ne rendono difficile la comprensione.
[20] Ben diversamente va valutata la posizione di soggetti imputati di concorso nell'eccidio delle Fosse ardeatine, in posizione apparentemente analoga a quella di altri concorrenti a suo tempo assolti (Cass., Sez. I, 16 novembre 1998, dep. 1° dicembre 1998, n. 12595, Hass, Priebke). La Corte di cassazione ha escluso la configurabilità di una contraddittorietà di giudicati, chiarendo che le assoluzioni pronunciate nel 1948 nei confronti di altri ufficiali tedeschi riguardavano soggetti ritenuti meri esecutori di un ordine superiore non percepito come manifestamente criminoso e quindi privi di dolo. Diversa era la posizione di Karl Hass ed Erich Priebke, i quali, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte militare e poi confermata in sede di legittimità, avevano avuto un ruolo decisionale e organizzativo nell’esecuzione della rappresaglia, con piena consapevolezza del carattere intrinsecamente illecito dell’ordine di fucilare dieci italiani per ciascun tedesco ucciso nell’attentato di via Rasella, e responsabili altresì dell’uccisione deliberata di cinque persone in più rispetto al numero prefissato, al fine di non lasciare testimoni. L’assoluzione per mancanza di dolo dei primi, dunque, non era in alcun modo incompatibile con la condanna per dolo pieno dei secondi.
[21] La sentenza Conforti (Corte di assise d’appello di Milano, Sez. 2^, 22 luglio 2015, Maggi + 2) è accessibile in rete tramite https://memoria.cultura.gov.it/documenti-online. Per quanto riguarda i punti più significativi di questa sentenza, con riferimento agli aspetti messi in evidenza nelle righe precedenti, si veda alle pp. 5-7, 81, 103, 142-143, 177-183, 374-384.

